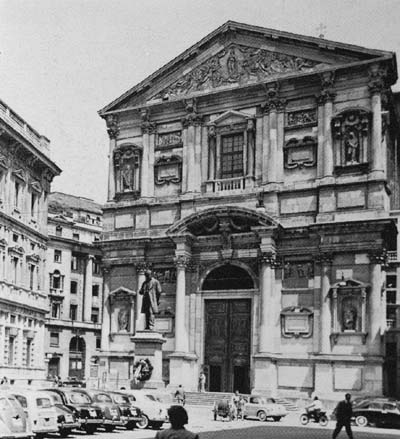DUOMO
Può
essere considerato il maggior tempio della cristianità dopo San
Pietro in Vaticano. I dati più interessanti: area coperta mq
12.000 circa; lunghezza m 157; larghezza m 93; altezza m 108; statue
oltre 3.000; guglie 135; capacità 38.000 persone.
Fatto costruire da Gian Galeazzo Visconti, che ne pose le fondamenta
il 15 marzo 1386, fu consacrato il 20 ottobre 1577 da San Carlo Borromeo.
L’edificio è di architettura gotica, eccettuata la facciata,
che è un insieme di vari stili. Questa facciata ha cinque porte
con battenti di bronzo; l’ultima opera dello scultore Luciano Minguzzi,
è stata inaugurata nel 1965. L’interno del tempio è
in forma di croce latina. Le navate sono divise le une dalle altre da
52 colonne a fascio che si slanciano altissime (m 25,39) a sostenere
le arcate ogivali e le volte. Tra le innumerevoli cose di interesse
storico ed artistico, segnaliamo il sepolcro dell’arcivescovo Ariberto
da Intimiano; il sarcofago dell’arcivescovo Ottone Visconti, col
quale s’iniziò la signoria viscontea a Milano; la grande
lastra marmorea con la serie cronologica dei 42 vescovi e arcivescovi
della diocesi milanese; il grande candelabro a sette braccia; detto
Trivulzio perché donato nel 1562 dall’arciprete Trivulzio.
In Duomo sono sepolti anche San Carlo e il cardinale Federico Borromeo.