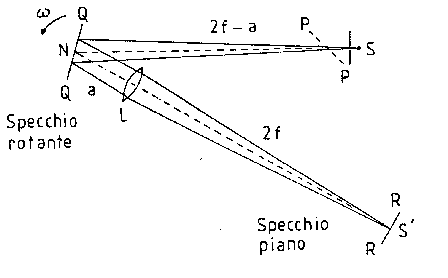 Fig.4.1.
Apparato di Focault modificato da Michelson
Fig.4.1.
Apparato di Focault modificato da Michelson4. MISURA DELLA VELOCITA’ DELLA LUCE
Scopo e descrizione dell’esperienza
Ci proponiamo di misurare la velocità della luce attraverso il metodo di Focault modificato da Michelson, che ha il duplice vantaggio di utilizzare basi di misura compatibili con le dimensioni ristrette del laboratorio e di consentire il confronto tra la velocità della luce in mezzi diversi.
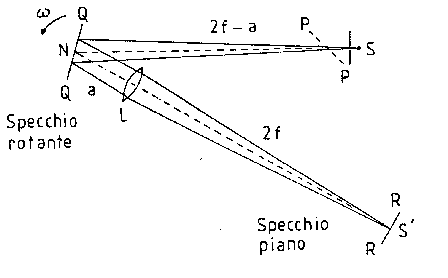 Fig.4.1.
Apparato di Focault modificato da Michelson
Fig.4.1.
Apparato di Focault modificato da Michelson
La luce viene emessa da una sorgente laser di piccola potenza posta in S grazie alla quale abbiamo un raggio molto ben direzionato e con una sezione di incidenza piccola e molto brillante. Dopo aver attraversato una lastra semitrasparente PP (come si può vedere in modo migliore dalla figura 4.1), disposta a 45° rispetto alla direzione di propagazione del fascio luminoso, facciamo incidere il raggio luminoso sullo specchio QQ rotante attorno ad un asse passante per N e normale al piano di incidenza del fascio. Lo specchio rotante è costituito da due facce riflettenti di alluminio ricoperte da una lamina di quarzo ed è fissato all’albero di un motore alimentato in corrente alternata (V= 220 V) e la cui velocità angolare massima è di circa 3000 rad/s. La velocità angolare può essere variata mediante un potenziometro, che purtroppo non è molto preciso e rischia talvolta di non mantenere una frequenza costante. Si usa un doppio specchio rotante per aumentare la luminosità dell’immagine.
La luce viene poi focalizzata da una lente L sullo specchio piano RR in S’.
La luce riflessa dallo specchio piano e successivamente dallo specchio rotante da’ luogo ad un’immagine che si discosta dalla sorgente S quanto più è elevata la velocità angolare w dello specchio QQ. Infatti nell’intervallo di tempo in cui la luce percorre la distanza NS’ lo specchio è ruotato di un angolo a e di conseguenza fornisce un’immagine spostata rispetto alla sorgente S. L’immagine che si forma è intermittente perché si produce solamente mentre S’ scorre sullo specchio piano RR, tuttavia noi percepiamo un’illuminazione costante perché la frequenza è troppo levata e l’immagine persiste già sulla retina dell’occhio appena si supera la decina di Hz.
La misura della velocità angolare dello specchio viene effettuata sfruttando il segnale elettrico fornito da una fotocellula inserita sul percorso del fascio luminoso riflesso dallo specchio rotante, come si può vedere dalla figura 4.2. che rappresenta in sostanza il nostro apparato sperimentale del laboratorio.
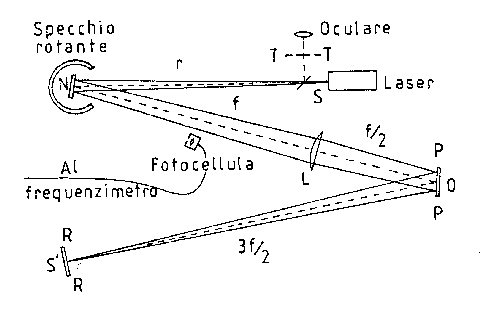 Fig. 4.2
Dispositivo di Focault - Michelson impiegato nell’esperienza di laboratorio
Fig. 4.2
Dispositivo di Focault - Michelson impiegato nell’esperienza di laboratorio
Il segnale elettrico viene inviato al frequenzimetro , tramite il quale abbiamo potuto misurare la frequenza w = p 2n . Il valore della frequenza misurato infatti è 2n poiché lo specchio rotante ha due superfici riflettenti.
Il dispositivo è stato realizzato in forma compatta inserendo uno specchio PP tra la lente L e lo specchio S’, in modo da rispettare le dimensioni del laboratorio. Dalle nostre misure risulta con un errore stimato di 0,5 cm:
LUNGHEZZE |
|||||
TS |
SN |
NL |
LO |
OS' |
LS'=LO+OS' |
cm |
cm |
cm |
cm |
cm |
cm |
15 |
391 |
373,5 |
119 |
505 |
624 |
Siamo stati attenti affinché il fascio di luce incidente fosse al centro della lente L e che l’immagine S’ sullo specchio RR fosse a fuoco.
Per l’aggiustamento ottico del sistema lo specchio rotante è stato posizionato manualmente nella direzione desiderata mediante una chiave che viene introdotta dalla parte superiore del cappuccio che protegge lo specchio.
Il cammino dei raggi ottici è stato osservato grazie alla diffusione della polvere del laboratorio.
L’osservazione dell’immagine prodotta dal fascio di luce laser su uno schermo TT (realizzato in carta traslucida) dopo che è stato riflesso da un vetrino di piccolo spessore ed inclinato di 45° (che nella fig.4.1. era PP) rispetto alla direzione del fascio proveniente dalla sorgente laser.
Sullo schermo traslucido appare un’immagine sdoppiata della sorgente in quanto il fascio di luce che ritorna verso la sorgente, dopo essere stato riflesso dai vari specchi, viene riflesso dalle due superfici del vetrino. Con uno spessore del vetrino di circa 1-2mm le due immagini sullo schermo sono separate da un tratto oscuro che è stato sfruttato per valutare meglio gli spostamenti subiti dall’immagine. Piccoli aggiustamenti degli specchi consentono di avere un’immagine ben definita sullo schermo traslucido. Lo schermo, fissato su una guida, può essere traslato ed il suo spostamento viene misurato con un micrometro.
Poiché la luce riflessa sul vetrino è ancora troppo intensa quando lo specchio è fermo abbiamo optato per una misurazione della posizione dell’immagine sullo schermo ad una frequenza di w 1~ 700 rad/s e successivamente quando la velocità angolare è massima w 2~ 3000rad/s. Non abbiamo potuto prendere frequenze molto più basse di 700 rad/s poiché il dispositivo di rotazione non teneva una frequenza stabile per il tempo necessario alla misurazione dello spostamento di delta. L’errore che abbiamo stimato sul doppio della frequenza è di 3Hz. In laboratorio abbiamo avuto a disposizione degli occhiali protettivi per la messa a punto dell'apparato e per la misura micrometrica dello spostamento d che abbiamo usato nel tempo indispensabile per le misurazioni.
Cenni di teoria e analisi dei dati
Per il calcolo della velocità della luce abbiamo preso 50 dati, cioè abbiamo misurato per 100 volte circa lo spostamento delta dei due punti luminosi alla frequenza più bassa e alla frequenza massima d ( 2n1) e d ( 2n2), ed abbiamo ottenuto il valore di d = d( 2n2) - d( 2n1).
2 n1 |
2 n2 |
d(n2) |
d(n1) |
d |
Hz |
Hz |
mm |
mm |
cm |
450 |
964 |
0,089 |
||
433 |
963 |
0,092 |
||
429 |
969 |
11,33 |
10,44 |
0,089 |
478 |
971 |
11,28 |
10,55 |
0,073 |
321 |
976 |
11,36 |
10,35 |
0,101 |
410 |
964 |
11,3 |
10,44 |
0,086 |
278 |
967 |
11,33 |
10,15 |
0,118 |
457 |
975 |
11,42 |
10,49 |
0,093 |
366 |
922 |
11,27 |
10,31 |
0,096 |
336 |
946 |
11,43 |
10,37 |
0,106 |
332 |
950 |
11,48 |
10,35 |
0,113 |
355 |
860 |
11,36 |
10,45 |
0,091 |
332 |
894 |
11,33 |
10,42 |
0,091 |
366 |
906 |
11,39 |
10,57 |
0,082 |
410 |
900 |
11,5 |
10,5 |
0,1 |
278 |
884 |
11,43 |
10,35 |
0,108 |
212 |
859 |
11,33 |
10,13 |
0,12 |
332 |
828 |
11,27 |
10,34 |
0,093 |
315 |
971 |
11,53 |
10,37 |
0,116 |
309 |
969 |
11,52 |
10,29 |
0,123 |
423 |
973 |
11,55 |
10,56 |
0,099 |
533 |
976 |
11,48 |
10,77 |
0,071 |
312 |
976 |
11,54 |
10,42 |
0,112 |
378 |
971 |
11,66 |
10,56 |
0,11 |
277 |
968 |
11,62 |
10,48 |
0,114 |
373 |
972 |
11,6 |
10,54 |
0,106 |
500 |
966 |
11,53 |
10,74 |
0,079 |
275 |
970 |
11,54 |
10,47 |
0,107 |
238 |
967 |
11,55 |
10,32 |
0,123 |
328 |
966 |
11,56 |
10,38 |
0,118 |
217 |
936 |
11,53 |
10,25 |
0,128 |
226 |
934 |
11,58 |
10,33 |
0,125 |
226 |
926 |
11,58 |
10,35 |
0,123 |
274 |
829 |
11,37 |
10,41 |
0,096 |
276 |
933 |
11,53 |
10,42 |
0,111 |
248 |
949 |
11,55 |
10,27 |
0,128 |
241 |
923 |
11,5 |
10,25 |
0,125 |
260 |
953 |
11,51 |
10,33 |
0,118 |
282 |
937 |
11,46 |
10,21 |
0,125 |
232 |
890 |
11,45 |
10,32 |
0,113 |
238 |
903 |
11,33 |
10,2 |
0,113 |
273 |
895 |
11,27 |
10,39 |
0,088 |
233 |
921 |
11,41 |
10,28 |
0,113 |
313 |
899 |
11,41 |
10,39 |
0,102 |
224 |
916 |
11,36 |
10,2 |
0,116 |
256 |
936 |
11,47 |
10,39 |
0,108 |
238 |
919 |
11,41 |
10,17 |
0,124 |
263 |
923 |
11,5 |
10,25 |
0,125 |
252 |
924 |
11,38 |
10,33 |
0,105 |
221 |
947 |
11,42 |
10,22 |
0,12 |
Sapendo che l’angolo a di cui ruota lo specchio QQ nell’intervallo di tempo in cui la luce percorre il cammino NS’N è dato da:
![]()
approssimando la velocità della luce a quella nel vuoto c.
Il fascio subisce uno spostamento
![]()
da cui sostituendo e sapendo che NS’ = NL + LS’ si ricava:
![]()
dalla quale si può ricavare la velocità della luce:
![]()
Possiamo quindi ricavare il valore di c dal grafico della miglior retta con 2n2-2n1 per ascisse e d per ordinata:
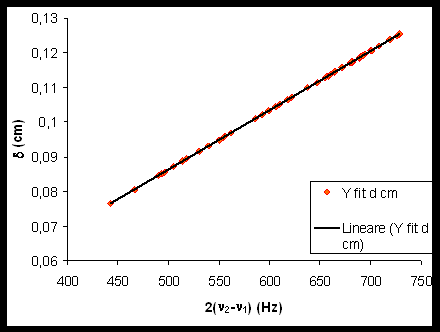
da cui calcolando il coefficiente della miglior retta che approssima i dati sperimentali attraverso il test del chi quadro e stimando l’errore commesso sulla determinazione di d come 0,01mm, possiamo ottenere per la velocità della luce il valore
c |
s(c) |
cm/s |
cm/s |
2,982E+10 |
3,3E+08 |
La misura di d viene effettuata con il micrometro che posiziona lo schermo traslucido in modo che l’immagine riflessa dal vetrino appaia centrata con il reticolo disegnato sullo schermo. Gli errori su questa misura dipendono sia dal grado di approssimazione con la quale si spostava il micrometro per raggiungere la posizione di allineamento con il reticolo, sia dal non perfetto allineamento del nostro occhio con l’oculare, sia dalla bassa luminosità dei puntini luminosi quando si va a frequenze elevate.
Per quanto riguarda la frequenza abbiamo riscontrato alcune difficoltà nel tenere costante la velocità angolare a frequenze basse per il tempo necessario alle misurazioni. Questo è dovuto al fatto che il motore del trapano che faceva girare il vetrino si spegneva se si andava sotto un certo numero di giri al minuto.
Ciò nonostante , anche grazie alla grande quantità di dati raccolti (50), il grado di precisione di questo metodo per la misurazione della velocità della luce in laboratorio è notevole, infatti sbagliamo solamente alla seconda cifra decimale ottenendo un risultato che si avvicina di molto al valore teorico della luce nel vuoto c = 2,998× 1010 cm/s.